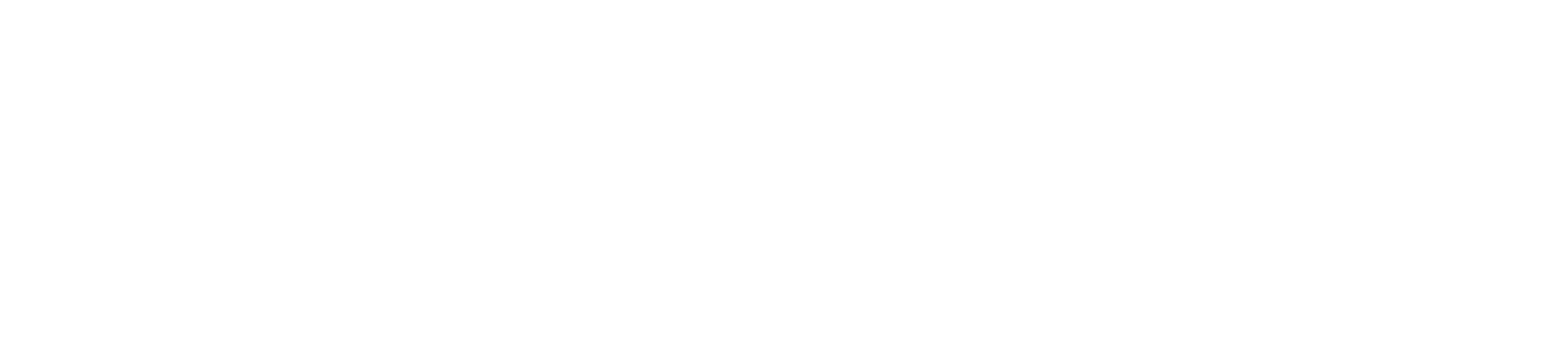Abstract
Affinché vi sia una comunicazione efficace ed effettiva ed il diritto possa essere meglio capito ed attuato correttamente e in modo efficiente è, preliminarmente, essenziale che la legge ed ogni fonte normativa sia “ben scritta”. Servono, dunque, buone regole intese non solo come leggi “scritte bene”, ma come leggi più consapevoli del proprio impatto su cittadini e imprese. Scrivere il diritto significa, infatti, anche dar luogo ad un vero e proprio procedimento di apprendimento legislativo nel quale la comunicazione giuridica si chiarisce e si specifica come capacità di dar vita ad un “cortocircuito” in cui i mezzi e i fini dell’azione pubblica siano collegati in maniera ragionata e culturalmente accettabile. È necessario, pertanto, porre
attenzione sui principali strumenti utilizzati dai diversi governi per poter concretamente progettare norme di buona qualità: analisi di impatto della regolazione (AIR); consultazione, tipicamente, se non esclusivamente nel contesto dell’AIR; semplificazione, spesso supportata da un’analisi di impatto; accesso alla regolazione; valutazione ex post degli istituti regolatori e degli specifici strumenti (VIR o AIR ex post) L’attenzione verso una ‘migliore’ qualità della normazione ha, del resto, assunto da tempo dimensioni globali: ben lontana dal restare confinata all’interno dei sistemi di regolazione nazionali essa ha, infatti, anche sotto la spinta di specifiche iniziative di organizzazioni internazionali quali l’OCSE, il FMI, il WTO, investito il dibattito politico e istituzionale internazionale e comunitario. In ambito europeo, in particolare, la prima tappa di un tale ripensamento critico intorno al law-making comunitario è stato il processo di ratifica del Trattato di Maastricht e, in particolare, il Consiglio europeo di Edimburgo del 1992. Nel 2002, dopo un processo di diverse esperienze in materia di valutazione di impatto, la UE si è dotata, nell’ambito del programma di azione sul migloramento della regolazione, di una procedura di valutazione di impatto delle principali iniziative legislative. L’introduzione di una tale procedura ha segnato, in ambito europeo, un importante cambiamento culturale all’interno della Commissione, diventando parte integrante della prassi di lavoro e del processo decisionale di questa istituzione, in grado di modificarne il modo di elaborare le politiche e, soprattutto, di migliorare l’elaborazione della normativa comunitaria.
Esta revista científica se encuentra registrada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Por lo tanto, esta obra se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente en formato digital, siempre que se reconozca el nombre de los autores y a la Pontificia Universidad Javeriana. Se permite citar, adaptar, transformar, autoarchivar, republicar y crear a partir del material, para cualquier finalidad (incluso comercial), siempre que se reconozca adecuadamente la autoría, se proporcione un enlace a la obra original y se indique si se han realizado cambios. La Pontificia Universidad Javeriana no retiene los derechos sobre las obras publicadas y los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores, quienes conservan sus derechos morales, intelectuales, de privacidad y publicidad.
El aval sobre la intervención de la obra (revisión, corrección de estilo, traducción, diagramación) y su posterior divulgación se otorga mediante una licencia de uso y no a través de una cesión de derechos, lo que representa que la revista y la Pontificia Universidad Javeriana se eximen de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de una mala práctica ética por parte de los autores. En consecuencia de la protección brindada por la licencia de uso, la revista no se encuentra en la obligación de publicar retractaciones o modificar la información ya publicada, a no ser que la errata surja del proceso de gestión editorial. La publicación de contenidos en esta revista no representa regalías para los contribuyentes.